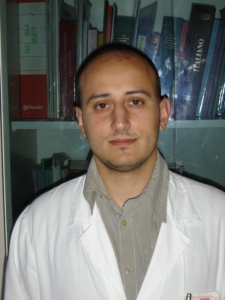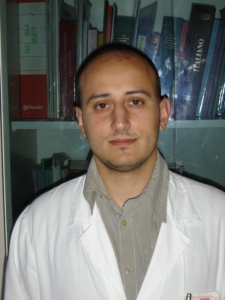
A cura del Dottor Piero Bruzzese, ginecologo presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica, Presidio Ospedaliero San Paolo, Polo Universitario, Milano
Gran parte delle donne che aspettano un bambino soffre di nausea, spesso accompagnata da vomito. Sono disturbi che interessano perlopiù la fase iniziale della gravidanza, e che di solito scompaiono spontaneamente in quella conclusiva. Per contrastarli efficacemente basta di norma seguire alcune buone regole alimentari, senza dimenticare che anche gli odori sono un fattore che può scatenare la nausea.
Nei primi mesi dell’attesa la futura mamma mostra infatti un’aumentata sensibilità agli odori, chiamata iperosmia gravidica, le cui ragioni non sono ancora state chiarite, ma potrebbero avere a che fare con un ancestrale ruolo di protezione nei confronti di sostanze potenzialmente dannose per il nascituro. Numerose sono anche le cause del vomito, non ultime quelle psicologiche legate all’ansia e allo stress.
In una ristretta percentuale di gestanti la nausea e il vomito assumono caratteristiche più gravi e debilitanti. In questi casi si parla di iperemesi gravidica, vera e propria malattia che impone il ricovero ospedaliero e la somministrazione di liquidi per via endovenosa, di vitamine e di farmaci, con esiti solitamente positivi.
Nell’85% delle gravidanze, in epoca gestazionale precoce, la donna va incontro ad episodi di nausea accompagnati, nella metà dei casi osservati, da vomito. Tali disturbi raramente si manifestano oltre la ventesima settimana dell’attesa.
Il “malessere mattutino”
Questa condizione viene descritta nella letteratura internazionale come “morning sickness”, malessere mattutino, poiché spesso la sgradevole sensazione che affligge lo stomaco si sperimenta nelle prime ore del mattino. Tuttavia non sono rari i casi in cui la sintomatologia si protrae nel corso dell’intera giornata o, addirittura, si sviluppa nelle ore pomeridiane e serali.
Nella maggior parte dei soggetti è un fenomeno autolimitantesi, e le future mamme vanno incontro a un progressivo miglioramento clinico, senza interventi medici, a mano a mano che la gravidanza prosegue. La nausea e il vomito sono condizioni ben note a tutte coloro che aspettano un bambino e, perlopiù, vengono accettate dalle donne come una “scocciatura” passeggera, una fase transitoria di cui si perderà il ricordo.
Nella tradizione popolare la persistenza delle nausee viene considerata addirittura come prova del perdurare dello stato gravidico e in effetti, in caso di aborto spontaneo, questo stato di malessere scompare nella quasi totalità dei casi.
Alcuni semplici consigli
Come già accennato, solitamente non è necessario nessun tipo di assistenza medica o terapia farmacologica e la donna gestisce il disturbo autonomamente, limitando gli sforzi eccessivi o evitando cibi e situazioni che stimolino l’insorgenza del malessere.
Anche qui la cultura popolare è una fonte dalla quale attingere a piene mani: nel corso della storia le donne hanno imparato a mangiare piccoli pasti alla volta e poco elaborati, in modo da non stimolare eccessivamente le papille gustative, e quindi la salivazione. Sono dunque preferibili piatti al vapore, privi di spezie, non troppo caldi, possibilmente accompagnati da pane o da cracker che assorbano l’eccesso di secrezione gastrica.
Sono altresì importanti il riposo frequente, anche solo per poche ore, ed un adeguato apporto idrico: anche se si potrebbe pensare che l’ingestione di acqua possa stimolare gli episodi di vomito, in realtà il rischio di disidratazione è sempre dietro l’angolo e un corretto bilancio di sali minerali aiuta a migliorare la sintomatologia. Un’altra accortezza da seguire è quella di evitare i luoghi eccessivamente congestionati o scarsamente aerati, quali i mezzi pubblici o i locali affollati.
In questo caso vi è una duplice componente che scatenerà la condizione di malessere di cui stiamo trattando: il caldo eccessivo e l’esplosione di odori.
Un olfatto ipersensibile
Per quanto concerne la percezione degli odori durante la gestazione, è d’obbligo discutere delle modificazioni nelle percezioni olfattive riscontrabili durante i mesi dell’attesa e, nello specifico, ad epoche precoci della gravidanza. Tale situazione è da sempre oggetto di studio, poiché tra i più frequenti cambiamenti lamentati dalle donne che aspettano un bambino vi è l’aumento della capacità di percepire odori che fino a qualche mese prima non si avvertivano: quel fastidioso profumo del collega che siede dall’altra parte dell’ufficio, le sfumature dei diversi ingredienti in quella ricetta particolare e, soprattutto, quel variegato odore di umanità e carenza di manutenzione che si annida non di rado nei mezzi pubblici.
In termini scientifici si parla di iperosmia gravidica, e i meccanismi alla base di questo fenomeno non sono stati ancora chiariti. Pare vi siano grosse somiglianze tra i recettori olfattivi e alcuni altri recettori deputati all’autodifesa dell’organismo da insulti esterni: non va dimenticato che la gestazione è a tutti gli effetti da considerarsi come un “trapianto” di un organismo che ha per metà un patrimonio genetico diverso da quello materno. Vi è inoltre la sensazione che l’iperosmia abbia un proprio ruolo ancestrale di protezione della gravidanza, acuendo la percezione di eventuali sostanze, presenti nell’ambiente o nei cibi, che potrebbero causare danni al nascituro.
Numerosi lavori scientifici hanno cercato il bandolo della matassa, ma i risultati sono poco convincenti. L’unico punto a favore dell’associazione tra iperosmia e vomito nei nove mesi è dato dall’osservazione che le gestanti anosmiche (vale a dire prive delle capacità olfattive) non incorrono pressoché mai in episodi di nausea.
Le tante cause del vomito
Ancor più sconfortanti sono i dati provenienti dalle centinaia di studi clinici volti alla scoperta delle basi patogenetiche del vomito nel corso della gestazione.
Vi sono decine di ipotesi ma nessuna certezza dimostrata e, come spesso accade per le condizioni complesse, non si può parlare di un singolo fattore scatenante l’insorgenza dei sintomi ma, in maniera sicuramente più appropriata, del concorso di diverse cause: fattori ormonali, innanzitutto, ricordando che all’inizio della gravidanza nel corpo materno operano due vere e proprie ghiandole createsi ex-novo (placenta e corpo luteo); fattori immunologici; alterazioni gastrointestinali dovute all’azione di ormoni o alle modificazioni anatomiche di adattamento alla gestazione; elementi psicologici.
Quest’ultimo punto, in particolare, andrebbe discusso ampiamente, poiché spesso si tende a sottovalutare il potere dell’ansia e dello stress in un periodo delicato come quello dell’attesa di un figlio.
Conflitti interni irrisolti, la paura di non essere adeguatamente preparata a sostenere il parto o il futuro ruolo di mamma, diatribe familiari: spesso dall’anamnesi eseguita al momento del ricovero emergono circostanze che mostrano come la sintomatologia che si cerca di curare con farmaci e ospedalizzazioni potrebbe in realtà essere mitigata da un colloquio approfondito e da una buona dose di serenità.
Le situazioni più gravi
In una minima percentuale di future mamme, l’1-2% circa, nausea e vomito sono incontrollabili e assolutamente debilitanti. In questi casi si parla di iperemesi gravidica ed è necessario il ricovero in una struttura sanitaria e un attento monitoraggio delle condizioni cliniche.
La malattia è più frequente nelle donne obese, nelle gravidanze gemellari e nei casi in cui la paziente ha già avuto iperemesi in una gestazione precedente. Ma cosa ci fa capire quando è il caso di preoccuparsi? Oltre alla frequenza degli episodi di vomito, dovranno essere ricercati segni quali disidratazione o tachicardia e sintomi quali una debolezza eccessiva o un forte dimagrimento.
Anche per quanto concerne la gestione clinica dell’iperemesi gravidica non vi è unanimità di pareri: esistono differenti approcci terapeutici, ma nessuna linea-guida universalmente accettata. Ciò è dovuto in parte alla già citata molteplicità di fattori scatenanti la patologia, in parte alla diversa suscettibilità personale ai farmaci e, frequentemente, alle differenti regolamentazioni in campo sanitario presenti nei vari Paesi.
Compito del medico è quello di riconoscere i casi di iperemesi gravidica, distinguendoli da quelle patologie che possono causare vomito (in gravidanza e non) e che beneficerebbero quindi di una specifica terapia farmacologica o chirurgica. Basti pensare all’infezione da Helicobacter pilori, alle gastroenteriti, alle malattie otorinolaringoiatriche, all’etilismo, alle infezioni delle vie urinarie, alle alterazioni della funzionalità tiroidea e alla bulimia.
Diverse terapie efficaci
Nella maggioranza delle pazienti, il solo ricovero associato alla somministrazione di liquidi per via endovenosa, risolve gran parte della sintomatologia. La terapia farmacologica può essere attuata quando necessario, senza timore di causare danni al feto, e consiste prevalentemente in una supplementazione di vitamine del gruppo B (B6 e B1 in particolare), eventualmente associate a molecole appartenenti a diverse classi farmacologiche che agiscono a livello del sistema nervoso centrale inibendo i centri del vomito.
L’uso di gastroprotettori è spesso consigliabile. La terapia non farmacologica si fonda sull’utilizzo dello zenzero (fresco, in capsule, in polvere o sotto forma di sciroppo) e sull’agopuntura a livello di punti specifici localizzati al polso. Ovviamente non va dimenticato l’aspetto psicologico e per tale ragione, nei casi in cui la terapia non risponde, un colloquio con uno psicologo potrebbe dare risultati positivi.
Per concludere, l’iperemesi gravidica è la forma più grave di nausea e vomito che si possa manifestare durante la gestazione, e non va sottovalutata. Una volta individuati i segni e i sintomi, è meglio affidarsi alle cure di un medico prima di iniziare una qualsiasi terapia a domicilio.
È giusto sottolineare i rischi per la salute materna e per quella del bambino, ma è doveroso precisare, allo scopo di evitare allarmismi, che le terapie sortiscono effetto abbastanza rapidamente e, nei casi trattati, non vi è un aumento di rischio per il proseguimento della gravidanza.